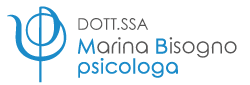19 Apr 2018
19 Apr 2018
Terapia di coppia
Comments: Nessun commento
Teoria dell’attaccamento
Secondo lo psichiatra infantile inglese John Bowlby, fondatore della Teoria dell’Attaccamento, il bisogno primario di ogni essere umano è quello di essere accuditi e protetti (Bowlby, 1988). L’attaccamento costituisce una motivazione innata a ricercare la vicinanza protettiva di un caregiver, ossia di un adulto percepito come figura stabile cui rivolgersi in caso di necessità o di aiuto.Le relazioni di attaccamento sono perciò i primi modi che ciascuna persona sperimenta per sentire se stesso e le proprie emozioni grazie alle relazioni affettivamente importanti che sviluppa con le persone che se ne prendono cura in maniera continuativa e dedicata. Nelle famiglie cosiddette normative, dove il piccolo cresce in ambienti affettivamente stabili e senza discontinuità nella disponibilità degli affetti:
-il 55-60% sviluppa un attaccamento sicuro
-il 15-20 % un attaccamento insicuro di tipo evitante
-il 10-15% di tipo insicuro ambivalente-resistente
-il restante 15% esibisce un pattern disorganizzato (non riesce a sviluppare una strategia coerente per garantirsi aiuto e protezione nei momenti di vulnerabilità, rimanendo in una condizione di maggiore vulnerabilità che può comportare alterazioni per lo sviluppo socio-emotivo successivo).
È quest’ultima la tipologia di attaccamento che caratterizza fino al 78% dei bambini allevati in istituti e orfanotrofi, e che grazie all’accoglienza in famiglia si riduce drasticamente attestandosi intorno al 30% circa dopo un periodo di almeno un anno di permanenza nella famiglia adottiva. I risultati appena menzionati, testimoniano la ristrutturazione progressiva delle rappresentazioni di attaccamento, e segnala, come un fattore di rischio per lo sviluppo socio-emotivo, quale la disorganizzazione di attaccamento, possa ridursi grazie a nuove relazioni di cura.È per questo che l’adozione è definita come una forma di intervento naturale, una sorta di “terapia naturale” per i bambini che hanno dovuto interrompere o non hanno conosciuto le loro famiglie di origine. Rappresenta un laboratorio eccezionale per studiare come, al di là del vincolo biologico che lega reciprocamente il figlio e i genitori, possano esistere apprendimenti emotivi grazie a nuove relazioni affettive che si creano all’interno della famiglia adottiva. Rimangono tuttavia alcune aree di problematicità del “recupero” adottivo e soprattutto alcuni bambini, insieme ai loro genitori, riscontrano maggiori difficoltà . L’età del bambino al momento del collocamento adottivo conta per il recupero delle sue risorse. Dal punto di vista del funzionamento del sistema dell’attaccamento conta in maniera precisa e diversa rispetto a ciò che comunemente intendiamo per adozione precoce o tardiva. I bambini collocati in famiglia entro i 6 mesi di età, la cui esperienza di separazione e abbandono ha avuto perciò una durata limitata, dopo 12-18 mesi di vita nella nuova famiglia adottiva presentano pattern di attaccamento che sono del tutto sovrapponibili a quelli dei loro pari allevati in famiglie biologiche. Oltre i 6 mesi di età aumentano invece in maniera significativa i tassi di insicurezza e di disorganizzazione. In questo senso, dal punto di vista della relazione primaria di attaccamento, solo un periodo di istituzionalizzazione molto contenuto può considerarsi senza effetti sul bambino, mentre l’avvicinarsi già del primo anno d’età espone il piccolo a una domanda crescente di figure di riferimento dedicate e stabili, la cui mancanza segna il suo sistema di attaccamento. L’assenza di una figura di accudimento primaria sembra dunque confermata come responsabile, anche a età molto precoci, di un incremento di vulnerabilità socio-emotiva.Se è vero che i bambini che arrivano dagli istituti presentano circa il 75-78% di disorganizzazione, dopo circa un anno di vita con la nuova famiglia adottiva riducono questo tasso a circa il 30%, conquistando quindi un notevole recupero in un arco di tempo relativamente breve.
Circa il 50% di loro svilupperà inoltre un attaccamento sicuro, ossia la forma più flessibile e adeguata di attaccamento, essenziale per un buon equilibrato socio-emotivo.
La ricerca condotta con i nuclei familiari biologici ha mostrato un’importante corrispondenza (intorno al 75%) tra attaccamento delle madri e attaccamento dei bambini, con percentuali più moderate per i padri. Anche nelle famiglie adottive, al di là del vincolo biologico, le strategie con cui i genitori regolano le loro emozioni grazie al loro attaccamento passano nella relazione con i loro bambini adottati. In particolare, a un anno dall’adozione la probabilità che un bambino abbia un attaccamento sicuro se ha una madre adottiva sicura è 6 volte più alta che la probabilità di essere insicuro. Quando, oltre alla madre, anche il padre ha un attaccamento sicuro, questa probabilità aumenta di 50 volte. Quando invece le madri stesse presentano attaccamenti insicuri o disorganizzati, associati a minor flessibilità nella regolazione delle emozioni, anche nei bambini è più probabile (nel 67% dei casi) che permanga un attaccamento insicuro e disorganizzato.Genera stress quando i genitori hanno dei lutti presenti nella loro storia di vita che non sono riusciti a elaborare e/o quando percepiscono poco sostegno dal partner nel loro ruolo genitoriale. In questi casi ad aumentare è proprio lo stress connesso alla qualità della relazione tra genitore e bambino, percepita come difficile.I genitori adottivi hanno risposto indicando che la maggiore fonte di stress sta nella nuova relazione con il bambino, indicando in tal senso un bisogno di essere sostenuti nel loro nuovo compito di genitori. Alcuni di loro hanno dato risposte eccessivamente minimizzanti indicando una difficoltà ad ammettere che il bambino è anche fonte di stress, oltre che di gioia.È fondamentale che la coppia acquisisca, durante il percorso adottivo, la consapevolezza delle esigenze e dei bisogni di un bambino istituzionalizzato, del suo vissuto, della sua storia e delle problematiche che incontrerà nella costruzione di un legame, staccandosi dal bambino immaginario fino allora costruito nella mente. Se ciò non avviene l’incontro rischierà di essere fallimentare perché non conforme a quelle che sono le proprie aspettative e in contrasto con le reali esigenze del futuro figlio. Il bambino non ha il dovere di soddisfare e colmare i bisogni degli adulti ma ha il diritto ad avere una famiglia, di essere amato ed accettato nella sua diversità biologica, somatica e culturale. Un primo tradimento che la coppia fa al bambino è il cambio del nome, che è il primo segno di riconoscimento e di esistenza, come se volesse cancellare il passato del proprio figlio, un passato scomodo, da dimenticare, che, invece, va rispettato ed integrato in una sorta di patto adottivo. Un motivo per cui le leggi straniere prevedono per le coppie dei lunghi soggiorni nel Paese di origine è perché possano conoscere direttamente il contesto dove è cresciuto il futuro figlio ed assimilare le sue abitudini (alimentari, relazionali, climatiche), comprenderle, rispettarle e riproporgliele successivamente nel nuovo nucleo adottivo. In questo modo il bambino si sente accettato nella sua individualità e non deve adattarsi a richieste che per lui sono estranee e difficilmente comprensibili.
L’adattamento, infatti, da parte del bambino ad un contesto non accogliente e a delle rigide aspettative della coppia, può far sviluppare un “falso sé”. Compito dei genitori è dare continuità all’identità del bambino, sostenerlo nella fase di elaborazione del suo triste vissuto per evitare che ci siano fratture tra il suo passato, il presente ed il futuro. Spesso i bambini adottivi sono portatori situazioni di abbandono, di solitudine, talvolta di maltrattamento fisico e psicologico; sono bambini traditi dalla vita. Le figure adulte che dovevano soddisfare i loro bisogni fisici e di protezione gli hanno inflitto un messaggio forte di rifiuto, di non esistenza e non riconoscimento. Sono bambini che non hanno sviluppato un legame di attaccamento sicuro così come è necessario per una sana ed armonica crescita della personalità. Il bambino abbandonato presenta sempre un ritardo nello sviluppo psico-fisico perché fin dalla nascita si necessita delle cure individuali e personalizzate; se ogni bisogno fisiologico (fame, sete, ecc.) e affettivo (contatto fisico, visivo, coccole ecc.) è prontamente soddisfatto, il bambino sperimenta dapprima la continuità nella soddisfazione dei suoi bisogni e poi l’affidabilità nei confronti delle figure adulte che si occupano di lui.
E’ fondamentale che la coppia sappia che il bambino che incontrerà ha dei bisogni da soddisfare:
-ha bisogno di essere accettato e benvoluto nonostante il suo comportamento negativo
-ha bisogno di essere smentito dalla convinzione che lui è cattivo e che, pertanto, merita di essere punito
-ha bisogno di essere amato e soprattutto di non subire un nuovo abbandono
L’adozione è un atto d’amore che richiede una grande capacità di donarsi e non la soddisfazione di un bisogno di essere genitore a tutti i costi.
L’adozione ha, infatti, successo solo se il bisogno della coppia si trasforma in forte e sincero desiderio di dare amore.